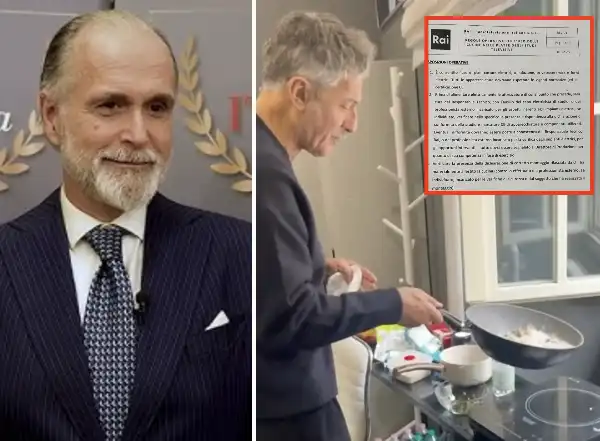UN MONDO DI RIN-DRONATI - ARRIVA IN ITALIA 'IL DIRITTO DI UCCIDERE', FILM SULLA GUERRA FATTA CON LE BOMBE DAI DRONI. VIDEO: HELEN MIRREN DÀ L'ORDINE DI BOMBARDARE ANCHE SE NEL BERSAGLIO C'È UNA BAMBINA - IL REGISTA: 'MANCA UN DIBATTITO PUBBLICO SUL DIRITTO DI UCCIDERE CHE GLI STATI UNITI SI SONO ARROGATI IN PAKISTAN, AFGHANISTAN E NON SOLO''
'Il Diritto di uccidere', clip dal film con Helen Mirren
Cristiana Allievi per www.gqitalia.it
Il colonnello inglese Katherine Powell, dopo aver inseguito per anni una connazionale divenuta terrorista, la rintraccia in Kenya grazie all’uso dei droni.
Il suo “occhio” sul campo è pilotato in Nevada da un giovane ufficiale che, al momento di sferrare l’inevitabile attacco alla cellula terroristica di Nairobi, intercetta una bambina che si piazza a vendere il pane proprio a pochi metri dall’obiettivo. A questo punto tutto ruota intorno alla percentuale di probabilità che ci sono di far morire anche quell’innocente, per colpire il gruppo di terroristi. Inizia un gioco di rimbalzi in cui nessun politico nella “war room” londinese vuole prendersi la responsabilità di decidere, mentre da parte Usa arriva più volte l’ok a procedere.
Nelle sale dal 25 agosto Il diritto di uccidere (Eye in the Sky), diretto dal premio Oscar Gavin Hood e prodotto da Colin Firth, solleva una domanda fondamentale nello spettatore: il danno collaterale è moralmente accettabile nel contesto della lotta al terrorismo?
«Non sapevo niente dalla moderna guerra con i droni, su cui tra l’altro non c’è mai stato un vero dibattito pubblico.
Per molti mesi ho studiato la sceneggiatura di Guy Hibbert, ho letto libri, guardato documentari e preso contatti con l’esercito. Poi ho parlato con piloti di droni e avvocati che si occupano di diritti umani», racconta Hood.
«Ma la cosa che mi ha coinvolto nel progetto, affascinandomi, è stato il fatto che al cuore della storia c’è un genuino dilemma etico e morale. Da ex avvocato mi ha ricordato il vecchio “dilemma del vagone”, spesso presentato alle lezioni di etica, in cui si chiede agli studenti se sacrificherebbero una vita per salvarne molte in circostanze che coinvolgono un treno in corsa che non si può fermare. Il diritto di uccidere pone lo stesso dilemma: uccideresti una bambina innocente per prevenire la possibile – ma non inevitabile – morte di molte persone per mano di un kamikaze?».
Come regista, Hood presenta questo dilemma allo spettatore in modo viscerale, cinematico ed eccitante, tenendolo inchiodato alla sedia e allo stesso tempo sfidando la sua idea di giusto e sbagliato. Interpretato dal premio Oscar Helen Mirren, da Aaron Paul e da Alan Rickman alla sua ultima e straordinaria prova di attore, il film è particolarmente abile nel far percepire cosa attraversano le persone a livello umano, dai vertici militari a quelli politici, fino al pilota che deve premere l’ultimo bottone della catena.
E mette in rilievo come questa nuova guerra non coinvolga solo una tecnologia avanzatissima, ma incastri leggi, etica e politica: il colonnello, per ottenere l’ok a procedere, dovrà prendere una decisione personale, che lascia lo spettatore con qualcosa di cui parlare e lo coinvolge al punto da farlo diventare una specie di giuria.
Che quello dei droni sarebbe stato il tema dell’anno lo si era capito con l’uscita di Good Kill, diretto da Andrew Niccol e interpretato da Ethan Hawke, seguito dalla proiezione di National Bird all’ultima Berlinale, il documentario di 90 minuti di Sonia Kennebeck prodotto da Wim Wenders.
Se il film interpretato da Ethan Hawke intrattiene con il tormento dell’uomo che passa dalla guerra fisica, combattuta in Afganistan, a quella in cui si uccide a distanza, freddamente e senza nessun tipo di percezione, la giornalista freelance Kennebeck, che ha lavorato per la CNN e le tv tedesche, ha fatto un altro tipo di operazione: ha cercato fonti interne e le ha fatte parlare direttamente, raccontando per la prima volta cosa succede a chi si arruola in “un programma di droni”, con tanto di numeri sui tentati suicidi per il disagio causato alla psiche.
Poche settimane fa Barak Obama ha finalmente rilasciato dichiarazioni sul numero di “vittime collaterali” dei droni dal 2009 al 2015: da 64 a 116 in sei anni è la cifra rivelata dalla Casa Bianca, un numero molto inferiore a quello dichiarato da media e Ong. Negli ultimi sette anni sono stati 473 gli attacchi degli aerei senza pilota contro obiettivi del terrorismo internazionale, che hanno ucciso circa 2500 terroristi. Il tema è quanto mai scottante, e secondo il New York Times la dichiarazione di Obama a sei mesi dalla fine della sua presidenza ha un valore simbolico: sarebbe un modo per rendere i bombardamenti al di fuori di zone di guerra una routine accettata della politica di difesa.
Per questo motivo il racconto dettagliato di cosa è la “kill chain”, che è al cuore di Il diritto di Uccidere, diventa un fatto quasi di utilità sociale, dal momento che questo tipo di guerra ci coinvolge tutti.
«È fondamentalmente la catena militare e politica del comando attraverso cui passa la decisione di colpire un individuo, prima che venga dato il via libera a ucciderlo», spiega Hood. «Nel film vediamo la catena in azione in tempo reale. Nel caso di un “individuo di alto valore” o di un target politicamente sensibile, questa catena della morte porta dritti al Primo ministro britannico e addirittura al presidente Usa.
Il fatto che a rendere legale un assassinio sia una catena di permessi è materia di grande dibattito. Se la gente parla di quello che ha visto, e di come la fa sentire, e di cosa farebbe e non farebbe se si trovasse a prendere decisioni sulla vita e la morte di qualcuno, ne sarei entusiasta. È l’effetto che ha fatto a me leggere la sceneggiatura di Guy: mi ha fatto davvero pensare».